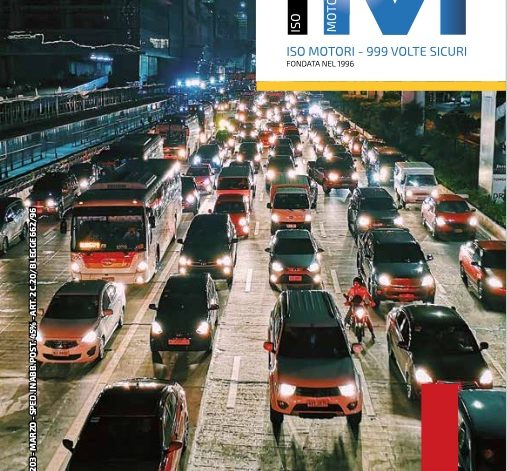Un’approfondita ricerca della Università della California a Davis ha indagato gli impatti della pandemia sulla mobilità. Uno dei dati più interessanti riguarda come è cambiato l’uso dei mezzi pubblici. L’8,1% dei rispondenti ha dichiarato di avere aumentato l’uso del trasporto pubblico, il 55,2% non ha cambiato abitudini mentre ben il 36,7% non ha più usato i mezzi pubblici. Di questi, il 35% ha sostituito il trasporto pubblico con l’auto privata e il 23% non ha cambiato abitudini. Il dato più interessante è che ben il 42% ha ridotto l’uso dell’auto, vale a dire c’è stata una riduzione netta della mobilità sostanzialmente grazie al lavoro da remoto. Sono aumentate le auto con un solo occupante e i ciclisti, mentre l’uso di altre forme di trasporto quali il car-pool, gli scooter a chiamata, i modelli sul tipo di Uber ecc. è rimasto complessivamente basso. Prima della pandemia solo il 10% si recava al lavoro a piedi, ma tale percentuale è aumentata al 16% durante la pandemia. La qualcosa dimostra che anche la forma urbana è cambiata rispetto alla fuga nei sobborghi dei decenni passati.I ricercatori californiani – Giovanni Circella e Rosa Dominguez-Faus – hanno rilevato che i lavoratori con i redditi più elevati sono riusciti a sostituire fino al 50% gli spostamenti grazie al telelavoro mentre questa percentuale è solo del 20% per i lavori a reddito più basso. In Italia, per esempio, i docenti universitari riescono in gran parte a fare lezione e ricevimento da remoto senza grandi disagi e in modo efficace. Anche le scuole medie hanno adottato l’istruzione da remoto con qualche polemica e disagio, ma anche non pochi vantaggi.
Il trasporto pubblico è sussidiato in tutti i Paesi. Si tratta di investimenti enormi e alte spese di gestione che sono pagate con le tasse dei cittadini, compresi coloro che non lo usano ponendo così un problema di equità. Nel corso del tempo, si è formata una lobby potentissima che opera per la costruzione di infrastrutture di trasporto e che assorbe continuamente risorse. Per non parlare che la costruzione di strade e reti di trasporto pubblico ha stravolto la forma delle città, dilatandole e costringendo a grandi spostamenti. La proliferazione dei centri commerciali è forse l’aspetto più evidente di questo fenomeno. Alla spartizione di queste ingenti risorse pubbliche partecipano ormai anche gli ambientalisti che sostengono infrastrutture di trasporto pubblico ad alto impatto ambientale anche quando non sono necessarie e soluzioni a minore impatto sarebbero più efficaci ed efficienti. Per esempio, con il passaggio ai motori elettrici, non ci sarà più l’equivalenza tra auto privata e inquinamento che era una delle ragioni per cui gli ambientalisti richiedevano più autobus, salvo poi accorgersi che nel complesso talora i vecchi autobus a gasolio che marciavano vuoti inquinavano più delle auto. La pandemia ha dimostrato che si possono ridurre nel complesso i movimenti e di conseguenza non servono più nuove strade, nuove ferrovie o autobus: quelli che ci sono bastano e avanzano se si opera una intelligente riorganizzazione e una meticolosa manutenzione. Semmai questa operazione richiede investimenti in intelligenza e nel cambiamento che comunque comporta dei costi. Già si sta pensando a decongestionare le grandi città e rivitalizzare i piccoli centri anche per motivi di igiene e di tutela da altre possibili pandemie.
Per un certo tempo era giustificato scaricare su tutti i cittadini i costi complessivi del trasporto pubblico poiché si riteneva che una maggiore mobilità consentisse vantaggi per tutti. Ma superata una certa soglia, che la pandemia ha evidenziato, i costi sono superiori ai benefici e quindi si deve fermare la spirale di una indiscriminata proliferazione di infrastrutture e di una mobilità fine a se stessa.